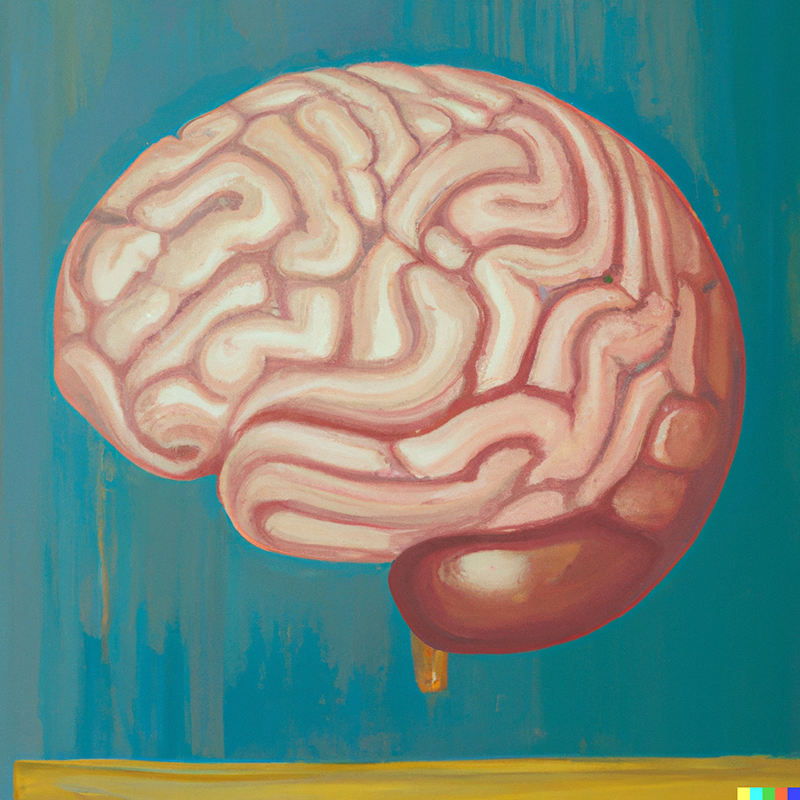
La malattia con la P
Prima che i dottori la chiamassero con quella precisa lettera dell’alfabeto, la malattia di mia madre aveva le sembianze fumose di uno spettro. Esisteva, ma si muoveva sullo sfondo, preferiva giocare a nascondino dietro a gesti impacciati, a passi incerti e movimenti insicuri. A tanti piccoli sbandamenti, come li definiva lei, non sapendo in che altro modo chiamarli.
Poteva essere qualsiasi cosa, poteva cominciare con qualsiasi lettera dell’alfabeto, persino con la C, la più temuta. Presto avremmo scoperto che l’ombra che si allungava dietro la mia amata mamma era la malattia con la P, un’eventualità a cui non avevamo mai nemmeno pensato, che sembrava capitare in sorte a persone che non eravamo noi.
Cominciò tutto una mattina di qualche anno fa, nel reparto di neurologia di un ospedale. Ricordo una sala d’attesa molto piccola, poche sedie e tanti pazienti. Uno in particolare, catturava l’attenzione. Uomo adulto, statura nella media, aspetto assolutamente normale, fatta eccezione per un piccolo, enorme dettaglio. La sua bocca, che un tempo doveva essergli appartenuta, sembrava avere vita propria; si apriva e si chiudeva a scatti, senza alcuna logica. E lui che tamponava la saliva con un fazzoletto mentre provava a parlare, e provava, provava, provava. Senza successo. Non potevamo sapere, allora, che quell’uomo soffriva della versione più acuta della malattia con la P, che ogni giorno doveva fare i conti con pillole, tremori, giramenti di testa. Con mille altri problemi. Allora sapevamo davvero poco, quasi niente.
«Vede, signora?» disse il dottore con voce rassicurante, durante la prima visita. «Il suo cervello non produce più una sostanza che prima produceva. Per rimettere le cose a posto, le dobbiamo reintegrare.»
Tutto molto semplice, fin troppo facile.
«La malattia con la P è assai comune oggi; certo, purtroppo ha una serie di effetti collaterali. Ma non si preoccupi, la sua è di lieve entità. È solo questione d’abitudine, mi creda. S’immagini una compagna di viaggio gestibile con qualche farmaco e un po’ di accortezze.»
Più ascoltavamo il dottore sciorinare dettagli, più ci chiedevamo se non ci fosse un modo per fare scendere quella sconosciuta dall’auto e tornare alla nostra vita di sempre. Noi non la volevamo, una compagna di viaggio.
«Non sto dicendo che la signora manifesterà necessariamente una ludopatia o una sindrome da acquisto compulsivo, però il mio dovere informarvi che è un’eventualità con questo farmaco. Il mio consiglio? Eviti di avere fra le mani una carta di credito.»
Ludopatia, sindrome da acquisto compulsivo: che avessimo sbagliato reparto?
«Signora, non si allarmi. Se non ha mai avuto interesse per l’una o per l’altra cosa, quasi sicuramente non svilupperà nessuna dipendenza. Per combattere la malattia con la P serve un eccitante per cavalli, diciamo così. I benefici che le apporterà saranno di gran lunga superiori ai fastidi, glielo garantisco.»
Gli abbiamo creduto. Peccato che all’inizio sia andata male. Il dosaggio era troppo alto. Mamma si lamentava che stava peggio di prima, che i giramenti di testa si erano aggravati, che l’entità dei tremori e degli sbandamenti cominciava a impaurirla. È successo che le pasticche che dovevano aiutarla un giorno l’hanno fatta cadere e lei si è trovata con delle vertebre rotte e un umore nero. Talmente tanto nero da lasciarci senza fiato. È stato in quel momento che noi tutti abbiamo compreso veramente la moltitudine di effetti collaterali che la malattia con la P si porta appresso. Non durante una visita specialistica, non in una stanza d’ospedale, ma vedendo una donna solare e piena di vita sull’orlo vertiginoso di una depressione.
Purtroppo è così, la malattia con la P si trascina dietro una carovana di lettere che quasi abbraccia l’intero alfabeto. Se fino ad allora pensavamo che non esistesse niente di peggio della C, ci siamo trovati a fare i conti con la malattia con la D, quella con la O, con la A…
Molte volte mi sono chiesta quando ho cominciato a pensare a me come a un’adulta. Ora conosco la risposta: il giorno in cui ho compreso che mia madre poteva arrivare a dimenticare tutto, anche se stessa, che tra sbalzi d’umore, ricadute e incidenti, poteva smettere di essere mamma e tornare a essere soltanto figlia.
Forse l’età adulta comincia quando si smette di nascondere agli altri la verità. Io ho smesso di spiegare che, sì, mia madre è malata, e che, no, quella precisa lettera non è più grave di tante altre, che è presa in tempo, che comunque tutto andrà bene con una pillola ogni due ore, per dodici ore, perché la medicina, si sa, ha fatto passi da gigante, perché oggi ci sono risorse che ieri, eccetera eccetera.
Non so di preciso cosa significhi essere aduli, indipendenti, maturi. Voglio credere che sia concedersi il lusso di piangersi addosso, abbracciare stretti qualcuno che ci ripete «smettila, mi fai piangere» mentre tu gli dici che così fa piangere te. Vedere finalmente il bicchiere non mezzo pieno o mezzo vuoto, ma soltanto ciò che è: un dannato bicchiere. Forse diventare grande è prendere un bel respiro e abbozzarla di chiamare la malattia neurodegenerativa di mia madre con una lettera dell’alfabeto. Forse diventare grande è smettere di assistere impotente al decorso del Parkinson, al suo interferire sulla salute mentale di una persona care. Le prospettive di una cura sono inesistenti, sì, però chiedere che le case farmaceutiche continuino a fare ricerca anche se i risultati non porteranno ai soliti guadagni miliardari, ecco, è esattamente ciò che farebbe una persona adulta. Giusto?
Immagine generata con DALL-E
“still life painting of a brain”